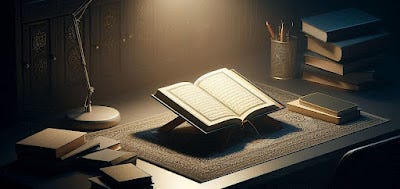Il Corano ha ispirato un lungo periodo di avanguardie culturali e scoperte scientifiche. Sebbene a questo siano seguiti dei secoli non altrettanto floridi, dove sempre più ci si è volti indietro, con lo sguardo sulla Terra invece che al cielo, ora, studiandolo a mente aperta, potrebbe avere qualcosa di nuovo da dire. Qualcosa, fra le tante, proprio su una delle più grandi questioni della nostra epoca, in ambito scientifico come anche a livello di cultura popolare: la vita extraterrestre. Andiamo dunque a esaminare se e cosa si può trovare nel testo coranico sull’argomento.
Il secondo versetto della prima sura, il primo se non contassimo la basmala ovvero l’invariabile versetto introduttivo (Nel nome di Dio, Misericordioso, Misericorde), recita:
“Lode a Dio, Signore dei mondi”.
La parola che traduciamo con ‘mondi’ è ʿālamīn ed è proprio un plurale. Il Corano inizia così, in modo francamente abbastanza diretto. Certo, si può intendere ‘mondi’ anche in senso astratto, cioè come diverse realtà, o come diversi domini tassonomici, e questo è ciò che fanno quasi tutte le esegesi classiche. Ma niente vieta il significato più concreto: diversi mondi cioè diversi pianeti. Ora per noi questa è quasi una banalità, e rischiamo di creare una proiezione delle categorie del presente. Ma è difficile pensare che all’inizio della predicazione di Maometto, quando ancora il Profeta aveva pochi seguaci che credevano nei messaggi che riceveva dall’alto, questa rivelazione, con il suo significato più immediato, non sia risuonata come una stranezza da riportare al significato che poi ha prevalso.
D’altra parte però i musulmani devono essersi abituati in fretta alle stranezze, perché a Maometto giungevano rivelazioni come questa (versetto 65:12) che riportiamo ricordando che il numero 7 simboleggia una quantità di elementi indefinita cioè infinita.
“Dio è Colui che ha creato sette cieli e altrettante terre. È posto fra di essi un ordine, affinché sappiate che in verità Dio è onnipotente e abbraccia nella sua Scienza ogni cosa”.
Sette terre cioè sette mondi, infiniti come i "cieli". Si tratta di mondi abitati, come la Terra? Collegando il versetto 42:29 parrebbe proprio di sì:
“Fra i Suoi segni vi è la creazione dei cieli e della Terra e degli esseri viventi che vi ha sparso. Egli è in grado di riunirli quando lo vorrà”.
Per quanto riguarda gli esseri viventi sparsi sulla Terra non vi è problema di interpretazione. Per gli altri si potrebbe pensare agli uccelli, se non fosse che la parola ‘cieli’ è al plurale (samāwāt) e pertanto indica in modo inequivocabile il firmamento. Un firmamento che, a quanto pare da questo e altri passi che ribadiscono il concetto (si riportano come esempio il 19:93, il 13:15 e il 30:26), pullula di esseri viventi:
“Tutti coloro che stanno nei cieli e sulla Terra non si presentano che come servi dinanzi al Misericordioso”.
“A Dio si inchinano, spontaneamente o di malavoglia, quelli che sono nei cieli e [su] la Terra, e le loro ombre, all'inizio e alla fine del giorno”.
“Appartengono a Lui tutti coloro che stanno nei cieli e sulla Terra. Tutti Gli sono sottoposti”.
Di che tipo di esseri si sta parlando? Sembra che non si dica niente di preciso in merito, invece delle piccole quanto preziose indicazioni si possono attingere. Intanto il fatto che abbiano delle ombre (13:15) ci dice che non si intendono esseri “spirituali” bensì in carne e ossa. O in qualcos’altro, ma comunque con una certa consistenza materiale. Inoltre la parola resa nel versetto 42:29 come ‘esseri viventi’ è dābbatin, letteralmente ciò che si muove, che è presente anche nel versetto 24:45 e ci informa rappresentare tutte le creature generate a partire dall’acqua:
“Dall’acqua Dio ha creato tutti gli esseri viventi. Alcuni di loro strisciano sul ventre, altri camminano su due piedi, altri su quattro. Dio crea ciò che vuole. Dio è onnipotente”.
L’ipotesi attualmente più accreditata nella comunità scientifica è effettivamente che la vita, per svilupparsi, abbia bisogno dell’elemento acqua. Si parla dunque, se non in modo esclusivo almeno predominante, di creature organiche.
Dalle esegesi classiche tutto ciò non emerge chiaramente, non lo si mette in relazione, non avendo i dotti del passato contezza che quella letterale potrebbe essere un’interpretazione plausibile dei passi, oltre che la più semplice. Come detto sono però le interpretazioni di questi dotti, che operarono senza a disposizione i nostri strumenti, a fare ancora scuola. Ma noi ora, consci della teoria della pluralità dei mondi abitati, possiamo leggerlo senza neanche fare – ormai impostata questa ermeneutica - troppi sforzi d’interpretazione. Passando a un livello successivo, possiamo e dobbiamo allora chiederci se gli esseri viventi in altri pianeti siano dichiarati come senzienti, e la risposta anche qua è affermativa. Il versetto 85:1 ci informa che, come noi, sono in grado di costruire edifici:
“Per il cielo, pieno di torri”.
Il cielo qui è quello a noi visibile, dove ci viene chiesto di immaginare delle costruzioni. La parola tradotta come ‘torri’ è infatti burūj, e non è un caso che molte esegesi tradizionali abbiano sofisticato il testo, e semplificato la comprensione per i canoni del passato, intendendola simbolicamente come ‘volte celesti’, ‘costellazioni’. Ma burj (forma singolare di burūj) nell’arabo comune ha il significato semplice e chiaro di ‘torre’. Possiamo andare a un livello ancora successivo scandagliando il Corano alla ricerca di caratteristiche su queste costruzioni. I versetti 14-16 della sura 15, seppur come sempre in modo conciso, ci danno molte informazioni su cui riflettere:
“Anche se aprissimo loro una porta nel cielo ed essi vi potessero salire continuamente, direbbero: «I nostri occhi vedono miraggi, siamo stati senz’altro stregati». Abbiamo messo in cielo delle torri, le abbiamo abbellite agli occhi di chi guarda.”
Cercando nei vari commentari qualcosa su questo ricco ma oscuro passaggio, non si trovano altro che letture simboliche, col cielo (samā’) che diventa il Paradiso e le torri che - senza alcuna correlazione con quanto detto prima - diventano costellazioni o simili. Noi rimaniamo sul piano letterale, e materiale, e vediamo cosa ne esce fuori.
Innanzitutto rileviamo che si parla di costruzioni talmente lontane dai nostri canoni (soprattutto da quelli degli uomini del VII secolo) che risulterebbero "magiche", cioè incomprensibili. Quindi, volendo dar credito a ciò che c’è scritto, si starebbe parlando di un qualcosa di esistente, perché c’è qualcuno che lo guarda (viene impiegato il participio nāẓirīna che si attua nel presente) e non siamo noi. Rimanendo alla spiegazione più semplice, e più concreta secondo i canoni attuali, la reazione di stupore può essere letta principalmente in un modo: la provocherebbe la vista di un qualcosa di immensamente più avanzato rispetto a ciò che un uomo del VII secolo, ma forse anche del nostro, potrebbe anche solo immaginare. Poi, cosa molto interessante, si accenna a un portale che aprirebbe un collegamento verso questi luoghi. Quindi nell’Universo, oltre ad altri esseri intelligenti e a costruzioni, secondo il Corano dovrebbero esserci delle vie di comunicazione, se non addirittura di trasporto. E infatti il versetto 51:7, accompagnandosi a quello sulle torri, recita:
“Per il cielo, percorso da attraversamenti”.
Cosa avrebbe potuto intendere di questi attraversamenti (ḥubuk) un uomo del passato, fino a quello recente? Non è difficile capire perché si sia pensato a qualche sorta di binari in cui si muoverebbe ciò che vediamo nel cielo, soprattutto quello notturno. A mente sgombra, sappiamo cosa se ne potrebbe pensare adesso: muoversi nello spazio è possibile ma non è, stando a ostacoli come le fasce di Van Allen che circondano la Terra, cosa semplice. E non lo è neppure secondo il versetto 55:33, che avverte:
“O jinn e uomini riuniti, se potrete varcare i limiti dei cieli e della Terra, varcateli. Ma non lo farete se non per [il permesso di] un'autorità”.
I jinn sono una specifica categoria di esseri senzienti che il Corano afferma essere stati destituiti dal ruolo precedentemente ricoperto, assimilabile a quello degli angeli, ed esiliati sulla Terra. La loro natura, essendo argomento pertinente, verrà trattata nel dettaglio più avanti, parlando di chi o meglio di cosa materialmente sono, secondo il Corano, gli informatori di Maometto: gli angeli.
Sulla vita extraterrestre possiamo fermarci qui. Come evidenziato da questa breve disamina, a cui si sarebbero potuti aggiungere tanti altri esempi, una volta impostato un certo assetto mentale è possibile riscontrare e affermare senza timore di smentita quanto segue: il Corano - chiunque venga considerato come il suo autore o meglio il suo gruppo di contributori - dichiara esserci nello spazio degli esseri viventi, di cui sicuramente alcuni senzienti, e la capacità, per noi, di entrare in contatto con loro.